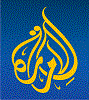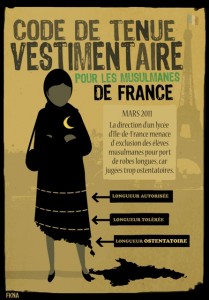Gli egiziani tornano alle urne per il ballottaggio che dovrebbe eleggere il nuovo Presidente della Repubblica in un clima di grande incertezza acuito dal recente scioglimento, da parte della Corte Costituzionale, del Parlamento eletto solo qualche mese fa. Questa manovra, tesa a disfarsi di un’assemblea “troppo” sbilanciata a favore dei fratelli Musulmani e della compagine islamista più estrema (salafita), conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, che le forze armate non hanno perso l’appetito per il potere, tanto da aver messo in atto questo colpo di stato incompleto. Se vincitore di queste elezioni dovesse risultare Ahmed Shafiq, loro candidato (Shafiq è un ex generale dell’ aeronautica), le forze armate avrebbero il controllo completo, l’ancient regime sarebbe restaurato e la primavera di piazza Tahrir vanificata.
Gli egiziani tornano alle urne per il ballottaggio che dovrebbe eleggere il nuovo Presidente della Repubblica in un clima di grande incertezza acuito dal recente scioglimento, da parte della Corte Costituzionale, del Parlamento eletto solo qualche mese fa. Questa manovra, tesa a disfarsi di un’assemblea “troppo” sbilanciata a favore dei fratelli Musulmani e della compagine islamista più estrema (salafita), conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, che le forze armate non hanno perso l’appetito per il potere, tanto da aver messo in atto questo colpo di stato incompleto. Se vincitore di queste elezioni dovesse risultare Ahmed Shafiq, loro candidato (Shafiq è un ex generale dell’ aeronautica), le forze armate avrebbero il controllo completo, l’ancient regime sarebbe restaurato e la primavera di piazza Tahrir vanificata.
Contro quest’ipotesi si scagliano tanto gli islamisti quanto i laici, ma, in realtà, alla maggioranza degli egiziani non piace né Ahmed Shafiq (e quanto significherebbe la sua elezione), né il suo oppositore, Muhamed Mursi, candidato dei Fratelli Musulmani. uomo privo di carisma e ubbidiente al Partito che diverrebbe il rappresentante di un Egitto decisamente sbilanciato verso una piena connotazione “religiosa” del Paese.
Tuttavia, molti laici, ma pure la componente Copta, sembrano preferire, tra i due mali, la soluzione Shafiq; ecco perché anche Mursi ha corteggiato i Copti dichiarando la sua disponibilità a farli partecipi del nuovo corso politico egiziano, e perché ha cercato di ammorbidire alcune posizioni dell’ala più conservatrice dei Fratelli in materia di controllo sulla società, parlando della non necessità di imporre il velo alle donne e dimostrandosi più possibilista dei colleghi di partito nell’apertura politica alle minoranze.
E’ pure vero che i Fratelli scontano la cattiva performance post elettorale e il conseguente scontento della popolazione, compresi i loro votanti, i quali s’illudevano, irrealisticamente, in un rapido miglioramento delle condizioni economico-lavorative del Paese. Molti hanno votato i Fratelli conoscendo il loro grande impegno sociale sul territorio, la loro rete di successo volta ad assicurare assistenza sanitaria e scolastica nelle zone disagiate, il loro rapido intervento a favore dei disoccupati e dei più poveri: ma reggere le sorti del Paese è altra cosa, soprattutto se si hanno le forze armate che remano contro. Ricordiamo che l’esercito controlla la risorsa principale del Paese, ovvero l’agricoltura, ma pure molte industrie nonché i lucrosi insediamenti turistici del Mar Rosso.
D’altro canto, per molti è difficile pure dare il voto a Shafiq, ex membro del partito di Mubarak, correo di tante azioni corrotte in compagnia dell’ex faraone e sospettato, tra l’altro, di aver ordito l’attacco delle “truppe cammellate” che hanno picchiato e ucciso alcuni manifestanti in piazza Tahrir nel gennaio 2011. Ecco perché, ad esempio, gli animatori del Movimento del 6 Aprile, uno dei gruppi di giovani egiziani più attivi nella “primavera”, considera piuttosto un’alleanza con i Fratelli Musulmani, qualora vincesse il loro candidato Mursi, ma esclude la possibilità di venire a patti con Shafiq.
Così, gli egiziani vanno alle urne per scegliere tra Scilla e Cariddi, mentre la vera sconfitta, al momento, è la democrazia, assieme ai suoi seguaci. In più, vi è l’incombente pericolo di nuovi e sanguinosi disordini nelle piazze del Paese, qualsiasi sia il verdetto delle urne.
pubblicato da Giornale di Brescia 17/6/2012