http://meykhane.altervista.org/recensioni.html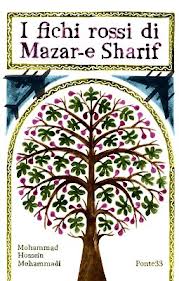
L’Afghanistan ospita storie letterarie che si esprimono in lingue differenti, le cui principali sono la dari, una variante del persiano, e il pashto, anch’essa appartenente al ramo orientale delle lingue iraniche. Rispetto al consorella, la dari vanta una più cospicua tradizione letteraria che da secoli si interseca (per motivi storici e culturali) con quella dell’Iran propriamente detto. Se nei secoli scorsi il flusso dei letterati tra occidente iraniano e oriente indo-afghano era virtualmente reciproco, dipendendo spesso dal mecenatismo di cui facevano sfoggio i rappresentanti delle diverse dinastie insediati ora sull’altopiano iranico ora tra le montuose valli del centr’Asia, nelle ultime decadi è indubbio che sia l’Iran a rivelarsi ricettivo per gli scrittori nati in terra d’Afghanistan. L’invasione sovietica prima e il regime dei Taleban poi hanno spinto milioni di profughi nei paesi confinanti, ma è proprio in Iran che che alcuni intellettuali afghani hanno trovato la via per frequentare corsi di scrittura creativa e poi, seppur con fatica, quella per pubblicare le proprie opere.
Nei secoli passati la letteratura afghana, come molte altre dell’area, compresa quella persiana, era soprattutto costituita da poesia, ma negli ultimi anni la prosa, specialmente nella forma del racconto breve sembra aver preso il sopravvento fra gli scrittori afghani, almeno tra gli uomini, mentre le donne sembrerebbero ancora legate alla lirica.1
Tuttavia, le circostanze storiche e sociali sembrano aver travasato nella nuova letteratura prosastica una sua componente essenziale, e, in alcuni periodi preponderante, ovvero il fakhr: letteralmente “onore, orgoglio, vanto”, in passato era una vera e propria forma retorica esprimente in una parte dell’ode (o in tutta) una serie di minacce e di violenze contro il nemico. Certo nella nuova letteratura il fakhr non si esprime in forma attiva, non c’è alcun compiacimento da parte dello scrittore in soldatesche smargiassate auto celebrative, ma, piuttosto, c’è il passivo subire una infinita tragedia bellica di proporzioni epiche dalla quale non ci si riesce a liberare.
Indubbiamente, le buone penne come quella di Mohammad Hossen Mohammadi (Mazar-e Sharif, 1975) riescono a rispecchiare verità intrise di atrocità trasfigurandole nel lirismo, in dimensioni oniriche, in quel realismo magico in cui scrittori di tutto il mondo spesso si rifugiano per evitare censure, o, semplicemente, attenuare i propri dolori. Attenzione, però, la raccolta presente non è l’ennesimo libro fabbricato per l’Occidente, dove improbabili cacciatori di aquiloni mescolano una sapiente miscela di temi politically correct per non scontentare nessuno, o, peggio, per giustificare ingiustificabili guerre. Apparentemente, Mohammad Hossen Mohammadi non accusa nessuno, neppure i carnefici, a loro volte vittime, si limita a guardare con occhio dolente una umanità resa disumana dalle circostanze, senza esprimere giudizi. In questo senso, la sua letteratura sembra distaccarsi da quella di un suo collega contemporaneo col quale purtuttavia condivide molto, ovvero Mohammad Asaf Soltanzade, il quale nella sua raccolta Perduti nella fuga (2000) si esprimeva con vena più politica e polemica, seppur stemperando i giudizi in una rarefatta area di magia, e puntava il dito contro tradizioni barbare, superstizioni, interpretazioni pseudo-religiose assurde.2
Nei racconti di Mohammad Hossen Mohammadi, invece, apparentemente non c’è nulla di tutto questo, l’Autore scandaglia, pone dinnanzi all’occhio del lettore un panorama angosciante di bambini orfani, ragazzi mutilati, donne stuprate e/o costrette alla prostituzione per sbarcare il lunario, soldati crudeli e impauriti, gente comune la cui natura umana è stata perduta per sempre. Tuttavia, anche nella sua assenza il giudizio dello scrittore è presente: così, se la scusa generale per i mali dell’Afghanistan è quella dell’incombente presenza della “religione”, l’Autore ne cancella ogni traccia. Anche il nome di Dio non è che un ritornello usato da un mendicante per farsi fare la carità che diventa addirittura il suo nome (Allah…Allah); oppure ricorre come invocazione a un dio minore, un surrogato di talismano pagano che la traduttrice, opportunamente, rende con la minuscola.
I racconti di Mohammad Hossen Mohammadi sono scomodi, inquietanti, disturbanti, ciononostante, oltre a costituire un esempio di prosa artistica ci ricordano l’ingombrante ma insopprimibile presenza di milioni di persone il cui destino resta sospeso fra montagne gelide e deserti infuocati.
Anna Vanzan
1Su questo v. il mio “Il doppio esilio. La poesia delle afghane rifugiate in Iran”, in El Ghibli, 5, 22, 2008: http://www.el-ghibli.provincia.bologna.it/id_1-issue_05_22-section_6-index_pos_1.html
2Mohammad Asaf Soltanzade, Perduti nella fuga, AIEP, S. Marino, 2002.